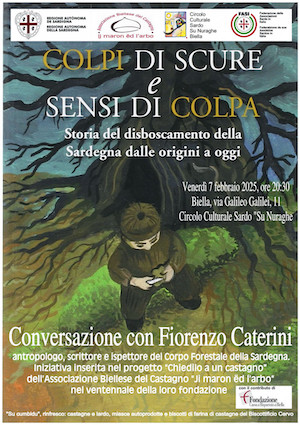 Iniziativa inserita nel progetto “Chiedilo a un castagno” dell’Associazione Biellese del Castagno “Ji maron ëd l’arbo” nel ventennale della loro fondazione
Iniziativa inserita nel progetto “Chiedilo a un castagno” dell’Associazione Biellese del Castagno “Ji maron ëd l’arbo” nel ventennale della loro fondazione
Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21:00, nelle sale del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, Fiorenzo Caterini – antropologo, scrittore, ispettore del Corpo Forestale della Sardegna – parlerà di “Colpi di scure e sensi di colpa”, storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi.
L’incontro è inserito tra gli appuntamenti del progetto “Chiedilo a un castagno” – campagna di promozione e adozione culturale del patrimonio castanicolo biellese, un progetto di Associazione Biellese del Castagno “Ij maron ëd l’arbo”, in occasione del ventennale della sua fondazione, promosso con il contributo del bando “Cultura+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
“Dagli antichi Greci fino ai viaggiatori dell’800, la Sardegna è sempre stata considerata un’isola mitica, florida, terra promessa ricca di boschi, acqua e risorse naturali.
Improvvisamente, – informa Carlo Delfino editore nel presentare l’opera di Caterini – verso la fine dell’800, l’immagine dell’isola si trasforma: terra brulla, inospitale, priva di risorse naturali e senza storia. Elemento geografico e umano si mescolano in una sorta di impietoso determinismo: la Sardegna altro non poteva forgiare che uomini rudi e vendicativi, dediti alla pastorizia e al banditismo.
L’isola mitica del passato è cancellata: la Sardegna è sempre stata così, arida e povera. Uno sguardo esterno che finisce per essere interiorizzato anche dai sardi al punto che, nel dopoguerra, con la petrolchimica e le servitù militari che premevano alle porte, nasce una concezione di Sardegna funzionale alle politiche economiche e statali dell’epoca. Una terra vuota, priva di storia, di cultura, di risorse naturali, pronta ad accogliere un ingombrante modello di sviluppo di importazione.
Per paradosso, esattamente il contrario di ciò che la Sardegna è in realtà.
Ma cos’era successo in quegli anni in Sardegna?”
L’autore di questo libro racconta i mutamenti che, a partire dai primi dell’800 e dal famigerato Editto delle Chiudende, hanno trasformato non solo l’ecologia dell’isola, ma, nel profondo, anche il rapporto dei sardi con la loro terra e con le risorse naturali.
“È stato calcolato – continua l’editore sassarese, che dal 1981 pubblica libri di cultura sarda guardando orizzonti più lontani – che, in quel periodo, i boschi della Sardegna si siano ridotti di almeno quattro quinti. È un disboscamento di mera speculazione, industriale, mercantile, che non va confuso con la normale agricoltura e la fisiologica dialettica tra attività tradizionali e bosco. Il bosco, fino ad allora organismo portatore di vita e di una complessa carica simbolica, viene abbattuto e ridotto a mero giacimento di legname. Con la radicale trasformazione ecologica si perde un intero mondo; è uno stravolgimento antropologico, che spezza il legame simbolico e funzionale tra gli esseri umani e la terra e li rende sempre più simili ad oggetti, a merce da comprare e vendere come forza lavoro.
La Sardegna entra così nella modernità, nell’economia di mercato. Con le vaste distese lasciate libere dal disboscamento giunge la monocoltura ovina, creando una nuova dipendenza dal mercato estero. Una dipendenza che permane e che rende la Sardegna, ancora oggi, vulnerabile alle attuali incombenti e drammatiche forme di speculazione, in triste continuità con il passato”.
E l’invasione fotovoltaica – continuiamo noi con sguardo dagli orizzonti alpini del Biellese – interessa oggi le terre isolane, con mostri eolici che si vogliono conficcare nelle acque prospicienti la grande Isola, non risparmiando neppure le turchesi acque del Golfo degli Angeli di Cagliari.
Incontro che si concluderà con l’immancabile “cumbidu”, rinfresco in versione “continentale” con castagne e lardo, “miasce” autoprodotte e biscotti di farina di castagne del Biscottificio Cervo di Biella.
Battista Saiu
Nell’immagine, locandina
